Prefazione di Piergiorgio Cavallini
Cui dono lepidum novum libellum ...?
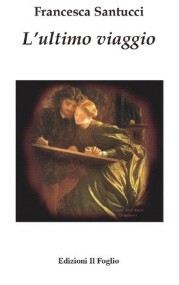
Vi sono diverse ragioni che m'hanno indotto a collocare a mo' d'epigrafe il celebre incipit catulliano a queste mie righe di presentazione dell'ultima "fatica" poetica di Francesca Santucci: un libellus, appunto, un libriccino (il "mio libriccino" di Montale), novus (e non solo nella datazione, perché contiene materiale molto recente, ma anche nella forma e nei contenuti rispetto ad altre produzioni dell'Autrice) e lepidus, "amabile", per usare la traduzione di Quasimodo. Amabile sia per quanto attiene alla partecipazione di chi lègge - mia in particolare - ed amabile perché parla d'amore - o dovremmo meglio dire dell' "Amore" - in diverse forme e sotto svariati aspetti. E qui è un'altra delle ragioni del ricorso a Catullo: le due anime del suo libro, le nugae e i carmina docta, le ritroviamo, mutatis mutandis, ne L'ultimo viaggio di Francesca Santucci, dove le prime saranno i componimenti brevi, quelli che hanno la natura come quadro di riferimento (gli animali, le piante, la notte, la spiaggia, il temporale ...) e le seconde, invece, le poesie classiche, le grandi passioni (Fedra ed Ippolito, Orfeo ed Euridice, Amore e Psiche, Ulisse e Parthenope ...) e i miti (le Moirai, le Menadi, Ade e Persefone ...). Chi scrive è filologo romanzo di formazione, traduttore di professione e fruitore d'elezione di poesie. Se il filologo esamina il testo scritto - anche quello poetico - indipendentemente dalle sue valenze estetiche ed artistiche, se il traduttore traduce su incarico "qualsiasi" genere di testo, il fruitore di poesie può, per sua fortuna, scegliere ciò che vuole lèggere in funzione delle sue preferenze, delle sue curiosità, dei suoi interessi. Il mio interesse è soprattutto classico, le mie preferenze sono per l'armonia, la musicalità delle parole; nella manifestazione artistica "l'abito fa il monaco", o meglio, "non si dà monaco senz'abito", intendendo con questo dire che, per interessarmi al contenuto, devo essere attratto dalla forma. E vediamola, allora, la forma di queste liriche. Se il versificare è moderno, "franco dai rudi vincoli del metro e della forma", per usare parole d'Arrigo Boito - che non rifugge dall'asindeto (ché già lanceolati/dorati tralci avviticchiati/ossigeno annaspanti infioravano; cupo precipizio/persi la rotta mi smarrii vagai/fluttuai nel sonno. Indi albeggiò/netti i contorni, nitide le sagome/illuminò/ delineò il chiarore,/) - l'ornatus è classico, con un uso sapiente delle figure: l'omoteleuto (canarino/paglierino, lanceolati/dorati tralci/avviticchiati); la climax (L’inattesa bufera s’abbatté, sradicò,/schiantò, svelse, divelse, seminò/la distruzione; mi smarrii vagai/fluttuai nel sonno); la paronomasia (contro il plumbeo cielo il vólto vòlto; more/amore; le more non amare con omografo che amare); la dittologia (brama ed agogna; la notte che più non rabbuia/e non annotta; attonito ristette/e sbalordì; battimi e percuotimi,/sferzami e scudisciami); il chiasmo (Chiede colore al sole, alla luna calore chiede); l'anafora (e allora m'ameresti,/sì, allora m'ameresti; t’involeresti ancóra /e ancóra… ancóra… ancóra…). E potrei continuare ma, così facendo, non renderei giustizia all'Autrice, che so curare la forma ma prediligere il contenuto, il messaggio universale affidato ai versi, nel caso di questa silloge il potere d'Amore, travestito con la metafora del viaggio, un viaggio finale, l'ultimo, ma anche un viaggio continuo, un continuo alternarsi tra un anelito di libertà
Spiccherei il volo di là da ponente,
un giorno di tempesta, rivolta verso oriente.
Forse lo troverei quel roseo varco
che congiunge al tramonto luce ed ombra,
quel raro frammento di luminosa luna
che abbaglia ed inargenta la tenebra notturna.
e il bisogno del giogo
Non subirò - mi dissi - l’amore
amaro più non subirò, ma poi
ancóra ai lacci i polsi, alla catena
il collo, docile e volontaria
volentieri offersi. E consenziente
schiava mi scoprii dolce avvinta
fra viluppi e legacci.
nel dubbio cosmico della sorte che accomuna uomini e animali: si pensi al cardellino in grata angusta costretto (e qui Francesca è debitrice del suo grande conterraneo Salvatore Di Giacomo) e alla formica persa nell’abisso dell’ordito, altrove/insignificatamente predisposto, un ordito di cui l'Autrice invoca la recisione
.... Oh tu
che lo stame della vita intessi,
tu che la giusta sorte assegni, tu
che l’ordito disfi, abbiate di me pietà,
implacabili il filo recidete!
Ma l'amore di Francesca Santucci è sempre e solo "Amore"? Spesso sembrerebbe essere semplicemente "amore", un amore terreno, anche se idealizzato
Docile mi lascerei
sorprendere dalle carezze,
in lotta con le tue labbra
vinta m’arrenderei ...
e allora m'ameresti,
sì, allora m'ameresti,
e fonte, sempre e comunque, di sofferenza
ma poi, come l’ ape che sugge
il nettare alla rosa,
t’involeresti ancora
e ancóra ... ancóra ... ancóra …
senza speranza
Mi sfinisce il giorno e m'offendono
gli squarci lame taglienti della luce,
e buio eterno che ferisce
è l'ora, da trascorrere lenta.
In narcotica agonia la lunga notte
attendo e poi sopporto, e subisco
l'indomani. Al risveglio l'identica
disperazione precedente: ancora
mi sorprende l'amore/dolore
senza lieto fine.
Continuerei, così, a lungo, con la pedanteria del filologo e l'entusiasmo del fruitore di versi, ma so di non poter abusare dell'ospitalità accordatami e mi piace concludere questo breve intervento, definendo "sintesi sublime" di classicismo e modernità i componimenti che seguono.
Piergiorgio Cavallini, ottobre 2002
